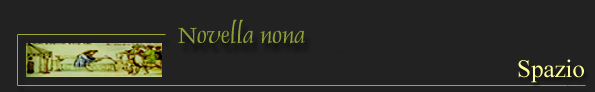
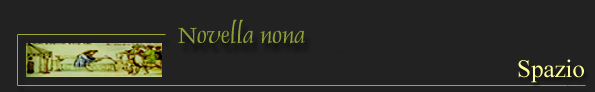 |
||||||||||||
|
In seguito agli scavi del 1965-1973 eseguiti sotto il pavimento di S. Maria del Fiore e nella piazza antistante la facciata, si sono trovati i due fondamenti sui quali poggiavano le due colonne nella loro prima collocazione (1117-1429), e che ci permettono di ridisegnare il luogo com'era ai tempi dell'accaduto.
Per quanto riguarda la presenza in età medievale di sepolture in arche e avelli intorno al S. Giovanni, e anche di tombe interrate nella piazza fra questo e S.Reparata, ci sono, oltre a quella del Boccaccio, testimonianze di cronisti e documenti di Archivio (cfr. CARDINI, p. 192, 1996): il Villani, parlando dell'abbattimento della Torre del Guardamorto avvenuto nel 1248, dice che era così chiamata perché "anticamente tutta la buona gente che moria si seppelliva a S. Giovanni" (Cronica, libro VI, cap. XXXIII).
Alcune delle arche menzionate nella novella, si conservano ancora ai nostri giorni: due sono nel Battistero, una agli Uffizi e, infine, due al Museo dell'Opera del Duomo: una di queste, esposta nel cortile del Museo è oggetto d'analisi nel saggio di
Watson, a cui rimando per tutto il discorso legato all'etimologia del termine "arca" e per le interpretazioni e associazioni da lui instaurate tra le figure scolpite sulla parte anteriore della tomba e la novella. Questo sarcofago "ha sul fronte tre nicchie divise da paraste scanalate: al centro è la porta dell'Ade da cui si affaccia Mercurio, guida dei defunti, con a fianco due Vittorie con trofei. Ai lati sono rappresentati i due coniugi defunti: l'uomo indossa la toga, ai suoi piedi sono il figlio e alcuni rotoli appoggiati su uno scrigno; la donna è velata, ed ha come attributi il pavone ed un fiore." ( materiale didattico dell'Opera di Santa Maria del Fiore, a cura di Claudia Soderi) Da questa breve descrizione e dall'immagine stessa dell'arca, balza subito all'occhio come la parte anteriore rechi scolpita un'opera architettonica, simile ad una casa, e se noi pensiamo che Boccaccio , a cui non era certo ignoto il ruolo escatologico di Mercurio (cfr. WATSON, p. 313, 1989) molto verisimilmente, poteva aver visto questo sarcofago esposto pubblicamente in piazza, allora l'associazione tra la casa dell'Ade qui scolpita e quella metaforica del motto cavalcantiano, non appare del tutto peregrina. Se non possiamo parlare di una fonte certa, purtuttavia non possiamo nasconderci il carattere suggestivo di questo dato. Si pensi infine alla mercurialità di Cavalcanti: infatti l'iconologia classica ci presenta Mercuruio come rapido ed eloquente; la parola è la speciale caratteristica di Mercurio, caratteristica anche della VI giornata del Decameron; l'eloquenza di Mercurio può diventare oracolare e criptica, come il motto di Guido; insomma "tutto questo ricorda l'impresa di Cavalcanti, una rapida risposta, una rapidità d'azione e di parola, una sparizione che lascia gli astanti sbalorditi. Cavalcanti, in una parola, è mercuriale" (WATSON, p. 314, 1989).
|