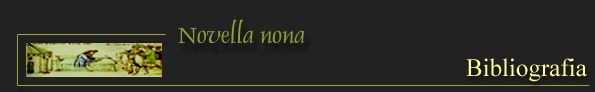
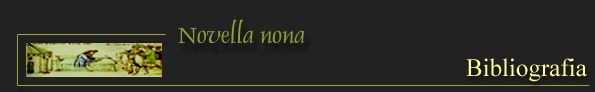 |
||||||||||||
|
BIBLIOGRAFIA Testi-Boccaccio - G. Boccaccio, Decameron, a c. di V. Branca, Torino, Einaudi, 1992, pp. 753-758. - Id., Decameron. Facsimile dell'autografo conservato nel codice Hamilton 90 della Staatsbibliothek Preussischer Kultur besitz di Berlino, a. c. di V. Branca, Firenze, Alinari, 1975, c. 76 r,v. - Id., Decameron. Edizione diplomatico- interpretativa dell'autografo Hamilton 90, Baltimore/Londra: The John Hopkins UP, Ed. Charles S. Singleton, 1974, pp.430-432. - Id., Trattatello in laude di Dante, Milano, Garzanti, 1995. - Id., Esposizioni sopra la Comedia, a c. di G. Padoan, Milano, Mondadori, vol. VI, 1965. - V. Branca, Tradizione delle opere di Giovanni Boccaccio, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, vol. II, 1979. - R. Fornaciari, Novelle scelte dal Decameron di Giovanni Boccaccio, Firenze, Sansoni, 1915. Testi - S. De Adam, Cronica, edizione critica a c. di G. Scalia, Bari, Laterza, vol. I, 1966. - La Bibbia, Roma, Edizioni Paoline, 1983. - Boncompagno da Signa, Cedrus, in Briefsteller und Formelbücher des elften bis vierzehnten Jahrunderts, a c. di Rockinger Ludwig, München, 1863. - D. Compagni, Cronica, Torino, Einaudi, 1968. - Gregoire lo Pape, Li Dialoge, a c. di W. Förster, Parigi, Paris librairie H. Champion, 1876. - Folgore da S. Gimignano, I sonetti dei mesi ed i componenti la brigata in una cronaca perugina del Trecento, a c. di U. Morandi, Siena, Cantagalli, 1991. - A. Manetti, Operette istoriche, a c. di G. Milanesi, Firenze, Le Monnier, 1887. - F. Petrarca, Rerum memorandarum libri, a c. di G. Billanovich, Firenze, Sansoni, 1945. - F.Sacchetti, Il Trecentonovelle, a c. di V. Marucci, Roma, Salerno Editrice, 1996. - F. Sansovino, Cento novelle, Venezia, Vecchi, 1610. - A. Schiaffini, Testi fiorentini, Firenze, Sansoni, 1926. - F. Villani, Le vite d'uomini illustri fiorentini, Firenze, Sansoni, 1847. - Id., De origine civitatis florentiae et de eiusdem famosis civibus, a c. di G. Tanturli, Padova, Antenore, 1997. - G. Villani, Cronica, Torino, Einaudi, 1979. Edizioni di Cavalcanti (ad esse si rinvia di solito con il solo nome del curatore; i saggi dedicati in maniera specifica a Donna me prega che riportano il testo della canzone ed hanno, in virtù delle scelte fatte, una rilevanza testuale, sono elencati tra gli Studi). - G. Contini Poeti del Duecento, a cura di G. Contini, Milano-Napoli, Ricciardi, tomo II, 1960. - L. Rossi Stilnovo, a cura di L. Rossi, entro l'Antologia della poesia italiana, diretta da C. Segre e C. Ossola, I. Duecento-Trecento, Torino, Einaudi-Gallimard, 1997. Dante Alighieri - Benvenuto da Imola, Comentum super Dantis Aldigherii Comaediam, a c. di J. Ph. Lacaita, Firenze, Barbera, 1887, vol. III, p. 314. - Divina Commedia, ed. naz. a cura di G. Petrocchi, Milano, Mondadori, 1966-67. - Lectura Dantis Turicensis - Inferno - a cura di G. Güntert e M. Picone, Firenze, Franco Cesati Editore, 1999. - A. Frugoni, Il canto X dell'Inferno, in Nuove Letture dantesche, Firenze, Le Monnier, vol. I, 1966, pp. 261-283. Studi-Giornata sesta - G. Bosetti, Analyse "structural" de la sixième journéé du "Decameron", in "Studi sul Boccaccio", VIII, 1973, pp. 141-158. - L. Cuomo, Sillogizzare motteggiando e motteggiare sillogizzando: dal "Novellino" alla VI Giornata del "Decameron", in "Studi sul Boccaccio", XIII, 1982, pp. 217-265. - F. Fido, L'"ars narrandi" di Boccaccio nella sesta giornata (1976), in Il regime delle simmetrie imperfette. Studi sul "Decameron", Milano, Franco Angeli, 1988, pp. 73-89. - G. Getto, Culto della forma e civiltà fiorentine nella sesta giornata (1957), in Vita di forme e forme di vita nel "Decameron", Torino, Petrini, 19763, pp. 140-164. - E. L. Giusti, La novella di Cesca e "intenderlo come si convene" nella sesta giornata del "Decameron", in "Studi sul Boccaccio", XVIII, 1989, pp. 319-346. - E. Grimaldi, Tautologie e autocelebrazione, in Il privilegio di Dioneo. L'eccezione e la regola nel sistema "Decameron", Napoli, ESI, 1987, pp. 205-218. - N. Mineo, La sesta giornata del "Decameron" o del potere delle donne, in "Rassegna Europea di Letteratura Italiana", 3, 1994, pp. 49-69. - C. Muscetta, Introduzione alla VI giornata del "Decameron", in Ritratti e letture, Milano, Marzorati, 1961; si veda anche la versione più recente contenuta in Boccaccio, Roma-Bari, Laterza 1972, pp. 245-54. - A. Paolella, Modi e forme del Witz, in "Strumenti critici", 36-37, 1978, pp. 214-235. - C. Oesch-Serra, Il motto di spirito: istruzioni per l'uso. Appunti per una lettura pragmatica della VI giornata del "Decameron", in "Versants", 17, 1990, pp. 3-16. - P. D. Stewart, La novella di madonna Oretta e le due parti del "Decameron" (1977), in Retorica e mimica nel "Decameron" e nella commedia del Cinquecento, Firenze, Olschki, 1986, pp. 19-38. - C. Van der Voort, Convergenze e divaricazioni fra la prima e la sesta giornata del "Decameron", in "Studi sul Boccaccio", XI, 1979-80, pp. 207-241. - G. M. Veneziano, La cornice a teatro: VI giornata, in Prospettive sul "Decameron", a. c. di G. Barberi Squarotti, Torino, Tirrenia Stampatori, 1989, pp. 97-111. Studi-Novella nona - P. Toynbee, An alleged note by B on "Inferno" XIV, in "Modern Language Review", XV, 1920. - A. Alfie, Poetics Enacted: a comparison of the novellas of Guido Cavalcanti and Cecco Angiulieri, in "Studi sul Boccaccio", XXIII, 1995, pp. 171-196. - M. Baratto, Realtà e stile nel "Decameron", Vicenza, Neri Pozza Editore, 1970. - L. Battaglia Ricci, Giovanni Boccaccio, in Storia della Letteratura Italiana, diretta da E. Malato, Roma, Salerno Editrice, 1995, vol. II, Il Trecento, pp. 727-877. - F. Bruni, Boccaccio. L'invenzione della letteratura mezzana, Bologna, il Mulino, 1990. - I. Calvino, Lezioni americane. Sei proposte per il nuovo millennio, Milano, Garzanti, 1988. D. Cardini (a cura di), Il bel San Giovanni e Santa Maria del Fiore. Il centro religioso di Firenze dal Tardo Antico al Rinascimento, Firenze, Le Lettere, 1996. - G. Carducci, L'epicureismo del Cavalcanti in una novella del Boccaccio, in Petrarca e Boccaccio, Bologna, 1944. - L. Caretti, Saggio sul Sacchetti, Roma, Bulzoni, 1978. - F. Chiappelli, L'episodio di Travale e il "dire onestamente villania" nella narrativa toscana dei primi secoli, in "Studi di filologia italiana", IX, 1951, pp. 141-153. - S. Contarini, La voce di Guido Cavalcanti: Jolles interprete di "Decameron", VI, 9, in "Studi sul Boccaccio", XXIV, 1996, pp. 209-217. - R. Durling, B on Interpretation: Guido's escape, in AA. VV., Dante Petrarch Boccaccio, Binghamton, 1983, pp. 73-304. - E. Fenzi, La canzone d'amore di Guido Cavalcanti e i suoi antichi commenti, Genova, il Melangolo, 1999. - F. Fido, L'ars narrandi di Boccaccio nella sesta giornata, in Le metamorfosi del centauro, pp. 43-61. - G. Getto, Vita di forme e forme di vita nel Decameron, Torino,Petrini Editore, 19763, pp. 140-164. - G.Inglese, Per Guido "filosofo", in "La cultura", XXX, 1992, pp. 75-95. - A. Jolles, La facezia di Guido Cavalcanti, in "Studi sul Boccaccio", XXIV, 1996, pp. 218-230. - E. Landoni, Strutture lessicali ricorrenti nel modello medievale del motto verbale arguto: il caso di "Decamerone" VI, 9 e dell' "Antica Vita" iacoponica, in "Testo, studi di teoria e storia della letteratura e della critica", XXII, 1991, pp. 74-81. - G Maetzke, Il cimitero alto medievale e medievale, in Il bel San Giovanni e Santa Maria del Fiore, a cura di Domenico Cardini, Firenze, Casa Editrice Le Lettere, 1996, pp. 191-201. - E. Malato, Dante, in AA. VV., Storia della letteratura italiana, diretta da E. Malato, Roma, Salerno Editrice, 1995, I, pp. 773-1051. - G. Mazzotta, The World at the Play in Boccaccio's "Decameron", Princeton, Princeton University Press, 1986, pp. 67-74. - R. Mercuri, Guido Cavalcanti o la metafora della cultura, in "Esperienze letterarie", II, 1979, pp. 55-58. - C. Muscetta, Introduzione alla VI giornata del "Decameron", in Ritratti e letture, Milano, Marzorati,1961; si veda anche la versione più recente contenuta in Boccaccio, Laterza, Roma-Bari 1972, pp. 245-54. - B. Nardi, Dante e la cultura medievale, nuova edizione a c. di Paolo Mazzantini, Bari, Laterza, 1985. - E. G. Parodi, La miscredenza di Guido Cavalcanti, in "Bullettino della Società Dantesca", XXII, 1915, pp. 37-47. - M. Picone, Codici e strutture narrative nel "Decameron", in "Strumenti critici", 11, 1987, pp. 438-442. - M. Picone, La brigata di Folgore fra Dante e Boccaccio, in Il gioco della vita bella. Folgore da San Gimignano, a c. di M. Picone, S. Gimignano, Città di San Gimignano Editrice, 1988. - E. Savona, Per un commento a "Donna me prega" di Guido Cavalcanti, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1987. - G. Sinicropi, Il segno linguistico nel Decamero, in "Studi sul Bccaccio", IX, 1975, pp. 169-224. - C. Soderi (a c. di), Gli edifici monunentali e le opere d'arte di pertinenza dell'Opera di Santa Maria del Fiore, Firenze,materiale didattico in fotocopie, 1999. - M. A. Staples, The ideology of the "Decameron", The Edwin Mellen Press, Lewiston/ Queenston/ Lampeter, pp. 89-101. - A. E. Quaglio, Prima fortuna della glossa garbiana a "Donna me prega" del Cavalcanti, in "Giornale storico della letteratura italiana", CXLI, 1964, pp. 336-368. - M. Veglia, Giovanni Boccaccio: Decameron (novella VI,9), in G. M. Anselmi, Breviario dei classici italiani, Milano, Mondadori, 1996, pp. 44-56. - Id., Per un Boccaccio "epicureo", in La vita lieta. Una lettura del Decameron, in Memoria del tempo, Collana di studi medievali e rinascimentali diretta da Michelangelo Picone, Ravenna, Longo Editore, 2000, pp. 15-56. - G. Velli, Seneca nel "Decameron", in "Giornale Storico della Letteratura Italiana", CLXVIII, 1991, pp. 321-334. - P. F. Watson, On seeing Guido Cavalcanti and the houses of the dead, in "Studi sul Boccaccio", XVIII, 1989, pp. 301-318; traduzione italiana di C. Abele e S. Rosso Mazzinghi nell'opera collettiva Boccaccio visualizzato, a c. di Vittore Branca, Torino, Einaudi, 1999, pp. 75-84. Opere sussidiarie - F. Cardini, Brunnelleschi, in "Dizionario biografico degli italiani", Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1979, vol. XXII, pp. 532-534. - Enciclopedia dantesca, (voce) "arche", Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1970, p. 348. - M. Marti, Cavalcanti, in "Dizionario biografico degli italiani", Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1979, vol. XXII, pp. 628-636. - G. Rholfs, Grammatica storica della lingua e i suoi dialetti: Sintassi e formazione delle parole, Torino, Einaudi, 1969, vol. III, p. 33. - Id., Grammatica storica della lingua e dei suoi dialetti: Morfologia, Torino, Einaudi, 1968, vol. II, p. 170. Materiale iconografico - D. Cardini (a cura di), Il bel San Giovanni e Santa Maria del Fiore. Il centro religioso di Firenze dal Tardo Antico al Rinascimento, Firenze, Le Lettere, 1996. - G. Fanelli, Le città nella storia d'Italia, Firenze, Roma-Bari, Laterza, 1984. Materiale sonoro - A. Stäuble, Lectura Dantis Turicensis - Inferno X (estratti), Zurigo, cassetta audio (copia) del 15-1-98. |