PAUL F. WATSON
Architettura e scultura e senso della narrazione: Guido Cavalcanti e le case dei morti*
Se vi guardate intorno, potrete capire. È questo il consiglio che Messer Betto Brunelleschi dà ai suoi amici sconcertati prima da una battuta spiritosa e poi da un salto di Guido Cavalcanti che balzava al di là di una tomba fuori del Battistero di Firenze. Guardare è anche il significato di ciò che segue: alcune osservazioni sul racconto di Guido Cavalcanti come il Boccaccio lo narra nel Decameron (VI 9). Non è un critico letterario che lo formula ma uno storico dell'arte, con lo scopo di arricchire la novella del Boccaccio con un commento separato e una interpretazione e una riflessione nuova su luoghi e fatti non ancora verificati di quella Firenze in cui il Boccaccio scrisse il Decameron, intorno al 1350 1. Quello che c'è da guardare con attenzione è una delle tombe sulle quali si accentra la storia del Cavalcanti: una tomba, che è, letteralmente, una dimora per il defunto. Betto Brunelleschi offre il suo suggerimento di "guardare", verso la fine di un racconto presentato al termine di una "giornata" dedicata a coloro che si salvano dal disonore, e peggio ancora, con le sole parole. La novella VI 9 è parte di una giornata di parole che giocano sulle parole. Eroe è un bravissimo fabbro di parole, Guido Cavalcanti, ancor oggi ricordato soprattutto come poeta. Dante, per esempio, allude all'arte poetica di Cavalcanti e alla sua crescente fama poetica mentre compie l'ascesa al Monte del Purgatorio 2. Alcuni anni prima di scrivere il Decameron, lo stesso Boccaccio rende omaggio ai versi di Guido nel Teseida, dove, nel commento dell'autore, una canzone di Guido Cavalcanti viene indicata quale chiave per quanto del testo si riferisce all'amore, alla sessualità e a Venere 3. Ma nel Decameron - ed è abbastanza interessante - il Boccaccio sceglie di affidare a Guido la parte di un filosofo assorbito da astruse speculazioni, manifestamente epicuree. Da molti anzi si dice che egli ponga in dubbio l'esistenza di Dio 4. Ciò che Guido ha da dire in questa "giornata delle parole", non è quindi un epigramma poetico, ma un'asserzione filosofica. Il lettore è messo in guardia sulla natura del discorso di Guido dalla narratrice del Boccaccio, una donna, Elissa. All'inizio costei specifica che quello che dirà il suo eroe è tanto più sottile e profondo del solito, "di tanto sentimento contato" (Decameron, VI 9, 3). Dopo aver stuzzicato i suoi compagni narratori, la "brigata" del Boccaccio, ella prosegue a delineare i personaggi. Al filosofo solitario Guido Cavalcanti, Elissa oppone Messer Betto Brunelleschi, cavaliere e patrizio fiorentino che incarna ciò che lei sostiene sia stato un costume particolarmente piacevole dei bei tempi passati: dei giovani che si riunivano in brigate cavalleresche per organizzare tornei e, tra gli altri divertimenti, anche parate a cavallo attraverso le strette strade di quella che era allora una piccola città medievale, Firenze. Guidando una tale comitiva, Betto desidera ardentemente che Cavalcanti, elegante e ricco quanto lui, si unisca al suo gruppo. Ma Guido, come osserva Elissa, preferisce la solitudine, che qualcuno può considerare come l'egoismo della contemplazione. Abbozzati e presentati i suoi personaggi, Elissa delinea anche un palcoscenico, pone insieme quanto necessario e mette in moto l'azione. Un bel giorno, Guido Cavalcanti sta compiendo il suo abituale giro, passeggiando dalla Chiesa di San Michele in Orto verso il Battistero, San Giovanni. Qui egli sosta nel luogo preferito, dove alcune tombe di marmo fiancheggiano la strada. Proprio in quel posto Brunelleschi e il suo seguito a cavallo incontrano il Cavalcanti e decidono di divertirsi un po'. Spronano i loro cavalli. Intrappolano il filosofo contro le tombe. Allora gli uomini di Betto chiedono allo sfortunato pedone di unirsi al gruppo, con un sarcastico rimprovero: " Senti un po', quando avrai scoperto che Dio non esiste quale giovamento potrai avere ? » Esattamente dice Elissa: « Guido, tu ti rifiuti d'esser di nostra brigata; ma ecco, quando tu avrai trovato che Idio non sia, che avrai fatto? " (VI 9, 11). Ciò che accade dopo è un'azione che palesa la vitalità della vita contemplativa come della vita attiva. Guido dapprima squadra i suoi torturatori, e poi dice semplicemente: " Signori a casa vostra voi mi potete dire ciò che vi piace ". Poi Guido appoggia la mano sul coperchio di una delle tombe del Battistero, volteggia oltre e sparisce, sano e salvo. Se il balzo di Guido elude quelli che avrebbero dovuto essere i suoi compagni le sue parole li interessano ancora di più. Alcuni si fermano al significato domestico di una parola, "casa", per dedurre che quello è uno spazio pubblico, che le loro case sono altrove e che ciò che essi hanno sentito non ha senso. Però Betto Brunelleschi è un ascoltatore attento ai significati impliciti. Guardate intorno (" se voi riguarderete bene "), egli dice, e guardate queste tombe, davvero esse sono le case dei morti, poiché qui i morti vengono deposti e hanno dimora. così noi siamo a casa, dopotutto, perché noi a confronto del Cavalcanti, uomo dotto, siamo peggio dei morti... Noi siamo "idioti". Mortificata, la comitiva di Brunelleschi batte in ritirata e non si divertirà più alle spalle di Guido. Ciò che Elissa narra è un gioco di parole che trae molto del suo significato da altre parole e da altri contesti. L'intuizione di Betto che queste tombe siano delle case riecheggia le parole del Salmista: " Sepulchra eorum domus illorum in eternum " (XLVIII, 12), come ha osservato per primo Parodi 5 . Ma la scrittura porta nella sua scia tradizioni di esegesi, sia patristiche che scolastiche, che dànno anch'esse un contributo all'esempio di associazione che questo testo crea 6. Il testo del Boccaccio ne rievoca un altro, la Divina Commedia, e quel magico momento nell'Inferno, X quando Dante conversa con il padre di Guido, Cavalcante, che come suo figlio è legato alla tomba, a parte il fatto che dimora in una di esse 7. Come sostiene Robert Durling, Decameron, VI 9 è, prima di tutto e soprattutto, una trovata verbale i cui termini e implicazioni possono divenire universali 8. Eppure Elissa inserisce la sua fiction in tempi storici. La morte di Guido Cavalcanti nell'agosto del 1300 fornisce, come dicono gli storici, un terminus ante quem per la datazione della azione che lei narra. Come Guido, Betto fu un personaggio storico che sopravvisse ai suoi nemici per molti anni. Egli fu anche il leader di un gruppo di cavalieri o, come lo chiama Elissa, una "brigata". Simili comitive proliferarono a Firenze durante il tardo Duecento, come testimonia il cronista Dino Compagni. Essi furono infatti gli strumenti della lotta più crudele tra fazioni. Guido Cavalcanti, infatti, scampò la vita per un pelo, così nota il Compagni, ma fu perseguito da una banda armata. In queste pagine Guido figura come un uomo solitario, altero e riflessivo. Betto è molto più socievole, ma anche, come lo dipinge il Compagni, un tipo losco: ricco e con buona fama, astuto, cattivo, brutale. Come riferisce un'altra testimonianza storica, Betto Brunelleschi era un tipo con cui non si poteva scherzare 9. La storia contribuisce a una lettura del racconto di Elissa che drammatizza il momento centrale e svela l'artificio narrativo. L'incontro tra Betto e Guido diventa il replay del Boccaccio di qualcosa che avvenne nel 1296, come dice Compagni, quando Corso Donati e i suoi uomini assalirono Cavalcanti nelle strade di Firenze 10. Qui però l'agguato ha una lieta soluzione. Come implica il senso del Decameron, VI 9 Cavalcanti si trova qui in un pericolo che potrebbe essere mortale e da cui si salva con la parola e con l'azione. Il suo è un atto di prudenza salva-vita. Di conseguenza la risposta di Guido rieccheggia le parole di un altro personaggio della VI giornata, madonna Filippa da Prato, che, minacciata dalla fiamma della giustizia, la spegne con la forza della sua eloquenza". L'equivalenza tra Filippa e Guido, tuttavia, è un problema di deduzione dalla storia, che suggerisce anche come il racconto più recente sia vicino alla verità. Quando Elissa parla delle bande armate di una generazione precedente, rileva che esse erano solamente una simpatica moda: "belle e laudevoli usanze" (Vi 9, 4). Niente nella sua esposizione rivela che questi gruppi fossero anche combriccole di assassini. Forse Elissa mente, o forse è più giusto pensare che usi la sordina circa la realtà storica cui si riferisce, quella della violenza imperante nelle strade della Firenze medievale; e questo per scopi tutti suoi, che riguardano esclusivamente le verità della sua narrazione, come dimostra il Durling. Quando Elissa parla di bande armate semplicemente come di una moda festosa, caratterizza i loro membri come degli epicurei, nel senso più comune della parola, gli antenati medievali degli attuali jet-setters e surfisti per rendere più evidente l'epicureismo più elevato di Guido. In modo simile, l'espressione di Elissa per indicare queste squadre, "brigate", stabilisce un contrasto tra Betto e i suoi compagni ed Elissa e i suoi pari, anch'essi una "brigata", però dedita all'ordine e alla virtù 12. Se il Boccaccio qui sta compiendo uno dei suoi giochi abituali con i documenti storici e con la memoria storica, allora ciò che accade al Cavalcanti "storico" viene totalmente travisato. Guido era uno studioso, come dice il Compagni, però era anche un litigioso. Audace per natura, la sua combattività era stimolata dal suo nemico mortale, Corso Donati, che tentò di assassinarlo mentre si recava in pellegrinaggio a Santiago di Campostella. Sfuggito a quella minaccia, Guido ritorna a Firenze e proprio nel 1296 scova Corso e sferra il primo attacco. E solo quando ha la peggio nella lotta che si dà alla fuga per salvare la vita da una banda da strada che, come pretende il Compagni, è uno stumento del diavolo 13. Nella vita Cavalcanti era un "bravo", ambizioso ed esperto, ma in questa storia si presenta semplicemente come un innocuo pedone. Qui, come altrove nel Decameron, il Boccaccio intreccia nel suo racconto elementi storicamente autentici, in parte per renderlo più persuasivo. La verisimiglianza è ancora pìù fortemente suggerita dalle circostanze di fatti del racconto di Elissa. Molto più del "chi" e del "quando", è il "dove" di questa storia che convince il lettore - specialmente coloro che sanno di architettura e di arte - che ciò è realmente accaduto. È facile per un fiorentino, o per un turista oggigiorno, ripercorrere a Firenze i passi di Guido Cavalcanti. Il suo viaggio comincia, come dice Elissa, a Orto San Michele (VI 9, 10), o Orsamnichele, ai giorni del Boccaccio, un "santuario con un granaio", a mezza via tra la piazza della Signoria e il complesso della cattedrale. Si può cominciare dalla porta orientale di Orsanmichele, incorniciata ora dalle statue rinascimentali del Ghiberti e del Verrocchio. Guido passeggia verso nord, lungo il corso degli Adimari (ora via Calzaiuoli) per raggiungere in pochi minuti piazza del Duomo. Qui un semaforo posto sulla Loggia del Bigallo risparmia i pedoni moderni da una confusione di autobus, Vespa e Fiat, tanto rapidi e tanto più letali di Betto Brunelleschi e dei suoi uomini. Passa oltre il Battistero. Un abbozzo di pianta (ill. 73), indica l'esatto itinerario di Guido 14. È ugualmente facile dedurre il luogo preciso dove sosta Guido. Qui il Boccaccio funge da "cicerone", specificando che il ritrovo preferito di Guido si trova tra la "porta di S. Giovanni" e certe "colonne di porfido" (VI 9, 10). Entrambi i punti di riferimento della novella ci sono ancora. Le colonne di porfido, un antico bottino lasciato a Firenze dai pisani nel 1117, ora fiancheggiano le porte del Ghiberti nella facciata orientale del Battistero, un edificio ottagonale. Al tempo del Boccaccio e fino al 1429 le colonne erano indipendenti dal Battistero per rendere l'area tra la chiesa e la cattedrale simile a una corte con colonnati simbolici 15. La porta di San Giovanni è l'entrata sud del Battistero, al tempo del Boccaccio da poco adornata dalle porte bronzee di Andrea Pisano (13 3 0-3 6): la prima decorazione monumentale del meraviglioso esterno di questo palazzo è anche un'indicazione del fatto che la porta sud era allora l'entrata principale 16.
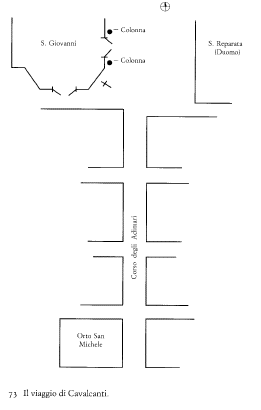
così Betto e i suoi uomini assalgono Guido sul fianco sud-orientale del Battistero. Nell'ill. 73, "x" indica il luogo. Gli uomini di Brunelleschi circondano Cavalcanti che sta davanti a certe "arche grandi di marmo". Adesso non stanno più lì, però il Boccaccio dice la verità. Una testimonianza obiettiva è nella cronaca scritta da Giovanni Villani dove si afferma che il Battistero per tutto il xiii secolo era circondato da tombe, "sepolture e arche di marmo", rimosse quando iniziò la costruzione dell'odierna cattedrale, nel 1296 17. Donde un altro terminus ante quem per il racconto di Elissa. Ancora di più, le tombe del Battistero sopravvivono ancora. L'ill. 74 porta un esempio. Come si vede, le tombe erano grandi sarcofagi, scolpiti in una bottega romana durante i primi secoli della nostra era e riutilizzati come tombe durante tutto il Medioevo. Il sarcofago nell'ill. 74 è ora nel cortile del Museo dell'Opera del Duomo, dove ce n'è anche un altro. Un terzo ora sta dentro il Battistero, e serve ancora come sepolcro per un certo Guccio de' Medici, ricordato come "gonfaloniere della giustizia" durante il 1300 18. Che il Boccaccio si riferisca proprio a questi sarcofagi lo dimostra la precisione del suo linguaggio. Lungo tutto il Decameron, VI 9 li chiama "arche di marmo", usando un termine alternativo e più generale, "sepolture", una sola volta (10, 11, 14). Connesso a questo c'è tutta una storia etimologica e un discorso che vale la pena fare. Nell'uso normale del xiii e xiv secolo, "arca" è degenerata, dalla sua originale nobile funzione, che indicava l'arca del patto divino o la nave di Noè, al significato di una semplice cassa o una cassaforte, un sinonimo di "cassa" o di "cassone", in una fase del linguaggio molto più avanzata. Dante trasforma il significato domestico di "arca" nell'Inferno, X, usandolo per indicare le tombe degli arcieretici, come il padre di Guido, Cavalcante, imprigionati in "arche di marmo". Descrivendo i sarcofagi, fatti come casse, del Battistero, il Villani riprende l'accezione dantesca della parola, come fa il Boccaccio, sia qui sia più tardi nelle Esposizioni quando glosserà l' "arca" di Dante per darle uno speciale significato di oggetto rettangolare simile a una cassa usata per contenere i cereali 19. In quel senso, l'oggetto mostrato nell'ill . 74 è una vera "arca di marmo". Il commento del Boccaccio su Dante, letto pubbli Ê camente ancora molto tempo dopo che il Decameron aveva cominciato ad essere conosciuto tra il pubblico, presenta un'altra e abbastanza notevole digressione sulle tombe, la loro forma, e i termini che le descrivono.

Dante cita molte parole, ma il Boccaccio limita con precisione la sua "arca" al sarcofago classico e tardoantico. Come esempi, egli segue Dante nel citare sarcofagi che ancora si possono vedere nella necropoli di Arles, ed è un'occasione per sagaci osservazioni sull'antichità di questi oggetti, i loro vari livelli di qualità artistica e, con deduzione proto-marxista, lo status sociale di coloro che un tempo li occupavano 20. Alla fine della vita il Boccaccio si comporta quasi come potrebbe fare un archeologo classico, ma questo è un ruolo che egli aveva assunto assai prima del Decameron, nella sua epica classicheggiante dell'antica Atene, il Teseida, caratterizzato com'è dal gusto del giovane Boccaccio per le forme e i monumenti del mondo antico 21. Leggendo Decameron, VI 9, è bene tenere presente un oggetto, l'antico sarcofago mostrato nell'ill. 74, e la parola che precisamente lo definisce come "arca". L'espressione del Boccaccio importa associazioni che includono la civiltà classica, il viaggio di Dante e la dimora eterna di Cavalcante. L'espressione ha anche un'esattezza morfologica in italiano, che l'inglese non è in grado di eguagliare. Due recenti traduzioni in inglese del Decameron traducono entrambe "arca" come tomb-stone, tanto per citare un esempio. Questo riduce l'oggetto che salvò Guido a qualche odierna, sottile lastra di pietra, un mero segnale verticale. Non solo ciò anglicanizza la favola fiorentina del Boccaccio, rendendo piazza Duomo simile a un cimitero nel quale i poeti possono comporre versi, ma priva anche l'azione di Guido di ogni plausibilità narrativa. Un bambino può scavalcare una pietra tombale, che non può nemmeno opporsi come serio ostacolo alla tattica della cavalleria 22. Un' "arca di marmo", simile a quella mostrata qui (ill. 74), se noi la osserviamo arricchisce la nostra valutazione della condizione fisica di Guido e del suo salto. Ciò che si trova dietro a Cavalcanti quando gli uomini di Betto lo circondano è una fila di casse di pietra, con pareti alte e spesse. Esse erano anche molto larghe. Il sarcofago, ora nel cortile del Museo della Cattedrale (ill. 74), e l'altro suo simile sono più alti di un metro: aggiungetevi un coperchio di un certo spessore e i sarcofagi subito sovrasteranno una Fiat 500, eguagliando l'altezza media degli uomini di seicento anni fa. Guido Cavalcanti può ora essere immaginato davanti a sarcofagi come questi, o addirittura a questo stesso: un baluardo di pietra. Egli se la cava, in quella difficile situazione, appoggiando una mano in cima a un' "arca" simile a questa (ma con un coperchio) e, in un battibaleno, volteggia e, con un movimento rapido, salta e scompare. I cavalli non possono inseguirlo attraverso lo stretto passaggio esistente tra l'arca e il muro sudorientale del Battistero. Come implica l'attuale sarcofago, Guido è certamente "leggerissimo", come dice Elissa (VI 9, 12) 23. Non è solo istruttivo per noi esaminare questi sarcofagi, ma ci sentiamo pure incoraggiati a farlo. Facendo fermare il Cavalcanti presso il Battistero, Elissa osserva come le "arche grandi", un tempo lì, ai suoi giorni si trovano altrove: "Oggi sono in Santa Reparata" (VI 9, io). Elissa intende l'attuale cattedrale, in costruzione intorno al 1350 e che ancora non aveva del tutto preso il posto della vecchia basilica, dedicata alla martire siriana Reparata. Un testimone più tardo annota che i sarcofagi furono poi disposti lungo il lato sud della nuova chiesa, dalla parte del campanile 24. In tal modo il narratore dirige l'attenzione verso uno spazio aperto a tutti, in caso che un lettore curioso possa voler vedere quale fosse l'ostacolo che Cavalcanti superò in modo così emozionante. Il sarcofago illustrato qui non è solo grande, ma anche in un certo senso "bello". 0, se non bello, almeno istruttivo. La parte anteriore fu scolpita nel III secolo da un artigiano romano di non particolare abilità, come quei maestri la cui opera ad Arles il Boccaccio ebbe più tardi a criticare (Esposizioni, IX, 1, 90-92) .

A sinistra e a destra di questa scatola di pietra stanno due figure, una donna velata da un lato e un romano togato dall'altro. Ciascuno sostiene una struttura architettonica, un tabernacolo, o un' edicola, formato da due colonne che sostengono un timpano ricurvo. Al centro un timpano triangolare incorona una porta i cui particolari lo scultore incide con dovuta, anche se meccanica, cura. Porta, colonne e timpani rendono la parte anteriore di questa "arca" simile a un'opera architettonica, simile a una minuscola casa. Come una casa, questo sarcofago ha pure un abitante. La cerniera della porta centrale si spalanca per rivelare un uomo nudo o piuttosto una specie di atleta eroico. In proporzione con la porta, ma minuscolo a confronto delle figure a fianco, egli esce come se intendesse affrontare un pubblico: l'aristocratica clientela dello scultore romano, gli odierni visitatori dell'Opera del Duomo, oppure i visitatori trecenteschi della cattedrale, come quel poeta dall'occhio acuto che era Giovanni Boccaccio. Quello che c'era da vedere conferma l'opinione di Betto Brunelleschi: guardate intorno a voi e vedrete una casa per i morti 25. Il sarcofago diviene un fattore che, come altri, tipo la durezza di Messer Betto, si oppone alla finzione del racconto di Elissa. Il sarcofago reca un uomo sulla porta, il maschio nudo, che suggerisce un curioso parallelo tra se stesso e Guido Cavalcanti. L'uomo sulla porta è muscoloso e atletico, come certamente lo è Guido. Egli abita per così dire in una dimora della morte, come anche Guido che per un certo tempo sta davanti al sarcofago poi volteggia via, dopo aver lasciato capire che questo è un'abitazione dei morti. E, come il Cavalcanti, il portinaio nudo è elusivo, ma non completamente celato, perché la porta è aperta, né interamente visibile come le figure oranti sui due lati. Come il filosofo, l'atleta è in movimento. L'atleta elusivo dell' "arca di marmo" del Battistero non è altri che Mercurio, la divinità che funge da messaggero degli dei. Egli rappresenta qui Mercurio Psichopompos, il dio che conduce le anime dei morti all'Ade. L'acutezza del moderno sapere classico, qual è rappresentato da Ruth Rubinstein e Phyllis Pray Bober, che hanno recentemente pubblicato questo sarcofago, ne spiegano il linguaggio figurato e spiegano la sua fortuna post-classica. Il Boccaccio non ebbe mai il piacere di leggere Renaissance Artists and Antique Sculpture 26. Tuttavia, sospetto che egli avrebbe facilmente decifrato l'identità di Mercurio e percepito il ruolo particolare che qui svolge. Mercurio, qui è Mercurio per ciò che indossa e per ciò che mostra. I suoi piedi calzano stivali, un copricapo copre la testa, e porta una bacchetta intrecciata con serpenti. Questi accessori, che erano molto più evidenti al tempo del Boccaccio, oltre seicento anni fa, oggi sono però sufficienti per identificare il dio. Familiari a noi per l'arte classica, essi sono anche gli attributi di Mercurio che si trovano nel testi classici, che il Boccaccio deve aver conosciuto a memoria. Quando Mercurio scende sulla terra per calmare Argo con le sue parole, così dice Ovidio, mette da parte i suoi calzari alati e la cuffia magica, ma tiene ugualmente la sua magica bacchetta 27. Mercurio e Argo sono anche figure ovidiane che Boccaccio ricrea come ecfrasi nei poemi scritti appena prima del Decameron: l'Amorosa visione e il Teseida 28. Gli attributi di Mercurio sono discussi alla fine delle Genealogle deorum, una delle ultime opere del Boccaccio 29. Ciò che egli dice è un ampio commento ai versi di un altro testimone classico, Virgilio, che nell'Eneide descrive la cuffia, i calzari e la bacchetta di Mercurio. Quel passo di Virgilio a sua volta attirò l'attenzione del Boccaccio, quando compose quella che sarebbe stata la sua opera epica di stampo classico, il Teseida. E quell'esercizio giovanile nell'imitazione dei classici suggerisce che il Boccaccio, vedendo l'antica "arca di marmo" fuori della cattedrale, ne avrebbe compreso la connotazione funeraria ed escatologica a prima vista. Il Teseida giunge al termine quando il cavaliere di Marte, Arcita, preparandosi a morire, fa sacrifici a Mercurio. Il suo ultimo atto terreno è in onore di quel dio, così che il suo spirito possa dimorare in un'amena distesa dell'aldilà, qual è l'Eliso. perché Mercurio, come si dice in un momento precedente del poema, è "colui / che l'anime da'corpi morti tolle" (IV 35, 2-3), che prende le anime dai corpi. E il Boccaccio stesso glossa il desiderio di Arcita morente: "Era opinione degli antichi che Mercurio doveva estrarre le anime [del morto] dai loro corpi e portarle dovunque gli piacesse" 30. Il Boccaccio, come glossatore, da nessuna parte specifica quali fossero le sue fonti, ma la consapevolezza del ruolo funebre di Mercurio proviene certamente da Virgilio. Mercurio scende dal cielo nel IV libro dell'Eneide per punire Enea a causa del suo indugio a Cartagine. Virgilio protrae le preparazioni per il volo. Prima Mercurio si mette ai piedi i sandali d'oro "alati per sorreggerlo, rapido come un turbine, alto attraverso terra e acqua". Poi raccoglie la sua bacchetta (Eneide, IV, 242-44): hac animas ille evocat Orco pallentis, alias sub Tartara tristia mittit, dat somnos adimitque et lumina morte resignat 31. Virgilio, in altre parole, presenta Mercurio come psichopompos. Quello è il suo ruolo nel Teseida, così come pone in rilievo la preghiera di Arcita morente; ed è un ruolo spiegato alla fine dal Boccaccio nelle Genealogie deorum. Ma è Virgilio che fornisce un modo per identificare Mercurio e la sua virga, o bacchetta, quali figurano nel sarcofago del Battistero. così il Boccaccio conosce il ruolo escatologico di Mercurio e con quali mezzi egli lo realizzava, e aveva qui anche un chiaro e visibile esempio del dio in azione, in un'opera d'arte antica perennemente in vista. L'associazione di Mercurio con il morto, come raffigurato nell'arte e nella poesia, induce a una rinnovata attenzione a Decameron, VI 9, dove Betto, contemplando un sarcofago, conclude di essere peggiore del morto. La rappresentazione si concentra sull'atletica figura del nemico di Betto, Guido, sfuggente come il dio muscoloso del sarcofago. Cavalcanti è anche molto simile a Mercurio quale lo presenta Virgilio, rapido ed eloquente. La parola, come mostrato dagli stessi versi di Virgilio, è la speciale caratteristica di Mercurio, proprio come Cavalcanti, che è ritratto da Elissa come un maestro del linguaggio: "parlante uom molto" 32. Come il Boccaccio doveva più tardi osservare nelle Genealogie deorum, l'eloquenza di Mercurio può spesso divenire oracolare e criptica, come lo è sicuramente qui la singola frase pronunciata da Cavalcanti 33. Di vivacissima intelligenza, Mercurio è ugualmente rapido nell'agire. Si consideri, per esempio, il suo ruolo nell'Eneide quando rimprovera Enea 34. Tutto questo ricorda l'impresa di Cavalcanti, una rapida risposta, una rapidità di azione e di parola, una sparizione che lascia gli astanti sbalorditi. Cavalcanti, in una parola, è mercuriale. Si può fare forse un parallelo più approfondito. Il Mercurio di Virgilio discende per castigare, ricordando all'eroe di Virgilio che egli trascura il suo regno futuro e il suo fato, "regni rerumque oblite tuarum", (Eneide, IV, 267). Il discorso oracolare di Cavalcanti serve per attirare l'attenzione d'un attento ascoltatore, Betto Brunelleschi, su un regno più sinistro: le case dei morti davanti ai suoi occhi. Brunelleschi giunge alla spiegazione (o forse così crede) delle parole di Guido proprio come quando si dice di Mercurio che, impugnando la bacchetta, apre gli occhi a coloro che sono morti. La frase di Virgilio "et lumina morte resignat" (IV, 244) si adatta al Decameron, VI 9 perché gli occhi di Brunelleschi sono aperti da ciò che accade, quando percepisce la sua vera condizione, di uno che è peggiore dei morti. Cavalcanti non impugna alcuna bacchetta per compiere ciò. Quello è lasciato alla sua controparte, Mercurio, ritratto nel sarcofago (ill. 74). Con le sole parole Cavalcanti eguaglia ciò che Mercurio compie con la magia. Un altro parallelo si suggerisce da sé. Sia Mercurio che Cavalcanti sono viaggiatori. Le peregrinazioni di Mercurio, descritte da Ovidio e da Virgilio, sono suggerite anche dal sarcofago, perché il dio che apre le porte dell'Ade indossa un copricapo, la cui forma e funzione persistono durante tutto il Medioevo: un copricapo a larga tesa che era portato da cacciatori, pellegrini, viandanti e altra gente in cammino 35. Pellegrino egli stesso nella vita, poiché si era recato una volta a Compostella in Spagna. Cavalcanti è anche un viaggiatore nella favola del Boccaccio. Diversamente dal modo di viaggiare di Mercurio, il muoversi di Guido è legato a cose terrene, limitato e curiosamente prestabilito. Come Kant a Königsberg, Cavalcanti a Firenze compie lo stesso percorso ogni giorno. La versione del Boccaccio per l'opera del filosofo si presenta comunque in modo tale da suggerire che Guido, come Mercurio, viaggi con un occhio all'aldilà. Nell'ill . 73 con " x " si indica la fine del viaggio. Guido incontra Betto e compagnia in un terreno consacrato, una necropoli in miniatura, posta fuori della chiesa. Ma questa chiesa particolare, San Giovanni, è il luogo dove si celebra il primo dei sacramenti, il battesimo. Sia la cerimonia dentro la chiesa che la sua forma esterna, il Battistero, portano all'inizio della vita cristiana, le cui regole, come costantemente ripetuto nell'esegesi patristica e medievale, coinvolgono la morte spirituale affinché possa esserci una rinascita spirituale 36. Se il Battistero porta con sé profonde connotazioni, così è per lo spazio che lo divide dalla cattedrale, l'odierna piazza del Duomo o, come Elissa la chiama, piazza di Santa Reparata, dove si trovano in questo momento gli uomini di Betto (VI 9, 10). In questo momento, nel tempo storico e narrativo, le colonne di porfido del Battistero erano libere, a suggerire che questo ampio spazio era la corte antistante la cattedrale. Nel linguaggio patristico e medievale l'atrio di una chiesa diviene un paradisus 37. Questo restò vero per Firenze. Le porte orientali del Ghiberti, collocate nel Battistero tra le colonne un secolo dopo che il Boccaccio terminò il suo racconto, sono chiamate "porte del Paradiso", proprio perché sono di fronte al paradisus 38. così Guido prende posto al margine di quello spazio (ill. 73). Egli prende posto davanti alle dimore di pietra di morti che aspettano la resurrezione in un luogo associato all'aldilà, definito come cristiano dalla liturgia, dai simboli architettonici e dalla stessa terminologia. Il Boccaccio ci costringe a considerare tutto questo perché le sue indicazioni topografiche sono precise e perché i tormentatori di Guido menzionano anche dove siamo. Uno dice: "ma ecco". Ciò può essere capito come un colloquiale "Guarda qui Guido", ma anche come una sollecitazione spaziale: qui come in Ecce homo. Colui che parla a questo proposito prepara la propria sconfitta per la risposta di Guido, "Ma ecco"; è una dichiarazione oracolare che prende significato da "ecco", proprio qui. Guido Cavalcanti raggiunge un paradisus architettonico alla fine di un viaggio che comincia proprio pochi edifici prima a Orsanmichele. Come osserva Vittore Branca quella chiesa era proprio dietro l'angolo per la casa di Cavalcanti in Por Santa Maria, la strada che va verso sud al Ponte Vecchio 39. Ma Elissa fa iniziare a Cavalcanti il suo viaggio nella chiesa. Andando da una chiesa a un'altra, Guido procede in una strada il cui nome trecentesco, Corso degli Adimari, potrebbe magari essere considerato come gioco sul nome dello storico e mortale nemico di Cavalcanti, Corso Donati. Cavalcanti inizia quel passeggio da una chiesa, Orto San Michele, dedicata a quell'arcangelo che, come il Boccaccio osserva in un altro punto del Decameron, s'impegna in una lotta col serpente, vale a dire con il diavolo 40. così guerreggiante descritto nell'Apocalisse (12, 7-9), Michele ricopre un ruolo ugualmente drammatico nell'ultimo giorno, il giorno del Giudizio, dove pesa le anime dei beati e dei dannati. Michele figura anche come avversario di Satana nella decorazione musiva della chiesa, dove Guido termina la sua passeggiata, il Battistero. Michele qui presiede alla resurrezione dei beati che, come i dannati il cui "comitato di ricevimento" è una torma di diavoli, vengono fuori da "arche di marmo" molto simili agli antichi sarcofagi posti all'esterno 41. Dato che le porte del Battistero sono chiuse nel giorno in cui Guido incontra Betto, queste istruttive immagini del xiii secolo rimangono nascoste: e Cavalcanti deve fare il suo discorso su vere arche che si trovano di fronte a un paradisus, il punto terminale del suo quotidiano viaggio. Come Mercurio Guido viaggia da un luogo all'altro, come Mercurio si può dire che Cavalcanti vada almeno col pensiero e per tramite delle architetture, da Orca a Tartaro. Forse egli ascende pure all'Eliso cristiano: perché nella sua impresa atletica fuori dal Battistero, volteggiando oltre un sarcofago largo e imponente, c'è qualcosa che suggerisce rinascita e resurrezione 42. Si dice che Guido Cavalcanti fosse un epicureo: ma l'opinione è contraddetta da ciò che fa, da dove va, da come usa le cose, da come usa un sarcofago che ricorda una casa. I suoi interessi sono escatologici. Il carattere della novella prende consistenza dopo aver letto le parole di Elissa, poche ma scelte con cura. Le sue parole e i loro riferimenti qui comprendono cose da vedere: strade, chiese, piazze lastricate e oggetti quali tombe di antica fattura romana. Il racconto di Elissa può essere compreso fino a un certo Punto, considerandolo semplicemente come un altro testo, poiché il Boccaccio lo costruisce il quel modo. Il lettore contemporaneo poteva trarre le sue conclusioni da parole essenziali: "S. Michele", "S. Giovanni ", "arca". Ma il Boccaccio dice anche dove queste si trovano e dove si possono ancora vedere. La narrazione diviene una serie di indicazioni topografiche, architettoniche e sculturali: "ma ecco". Se facciamo attenzione a questi segnali ecco che il racconto di Elissa assume colori e chiaroscuri. Il mondo quotidiano del centro di Firenze si riflette anch'esso sulla sua narrazione, provocando nuove associazioni, interpretazioni diverse. Un determinato sarcofago (ill. 74) non può da solo rivelare tutti i misteri di Decameron, VI 9, però in qualche modo aiuta a definirli. Soltanto guardare, come dice Betto Brunelleschi: "riguarderete bene". L'arte che comprende tanto gli edifici, quanto le sculture diventa la zavorra che dà equilibrio e senso alla favola.
Traduzione dall'inglese di C. Abele e S. Rosso Mazzinghi. * Da "Studi sul Boccaccio", XVIII (1989).
1 -Il testo qui usato è BOCCACCIO 1980a.
2 -Purgatorio, XI, 97-98: "così ha tolto l'uno all'altro Guido / la gloria della lingua".
3 -BOCCACCIO 1964b, P. 464, commentando VII, 50, 1.
4 -Decameron, VI 9, 8-9. Nota che considerazioni sull'opinione di Guido e convinzioni sono tutte dicerie: "si diceva tra la gente comune".
5 -PARODI 1915, PP. 37-47.
6 -Cfr. BOCCACCIO 198oa, P. 753, n. I. Si può aggiungere che quel riferimento di Betto ai suoi uomini e a se stesso come "idioti" risuona come un pensiero patristico sulla massa e su chi è illuminato: cfr. BROWN 1981, pp. 18-19, 137, n. 65.
7 -Inferno, X, 52-72.
8 -DURLING 1983, pp. 273-304; un articolo cui debbo molto, e questo mio contributo ha lo scopo di esserne un complemento.
9 -Cfr. nel DBI la voce di MARTI 1979, pp. 628-36, con la ricca bibliografia, e, per osservazioni sul personaggio leggendario del Decameron, VI 9, p. 633. Per Brunelleschi consulta sempre nel DBI la voce di CARDINI 1972, pp 532-34. Questi studi storici dimostrano che Brunelleschi e Cavalcanti appartengono alla medesima generazione e che furono attivi dall'inizio del 1280 in poi. Cfr. anche COMPAGNI 1978, specialmente le pp. 48 e 49 per Guido, che egli caratterizza come un uomo " cortese e ardito ma sdegnoso e solitario e intento allo studio " (1, XX, 58). C'è una bella versione in inglese con un commento breve ma utile: COMPAGNI 1986.
10 -COMPAGNI 1978, pp. 48-49. Anche COMPAGNI 1986, pp. 23-24
11 -Cfr. PENNINGTON 1977, pp. 902-5.
12 -DURLING 1983, pp. 282-83 e 292, n. 3; BRANCA 1997a, PP. 31 sgg.
13 -COMPAGNI 1978, pp. 48-49 e anche p. 53: " Il diavolo, accrescitore de' mali, si fece da una brigata di giovani che cavalcavano insieme" (1, XXII, 53).
14 -Cfr. altresì la pianta pieghevole, in COMPAGNI 1978, di fronte a p. 198, che mostra Firenze come era ai tempi di Cavalcanti.
15 -Cfr. BOCCACCIO 198oa, P. 756, n. 8 per ulteriori riferimenti.
16 -Cfr. la breve trattazione di POPE-HENNESSY 1972, pp. 190-91. Risulta chiaro dalla documentazione che tutte e tre le porte all'inizio dovevano essere state fuse in bronzo (1322) ma nel Trecento soltanto una di esse venne eseguita in tal modo, la porta meridionale d'Andrea, che indica l'orientazione principale del Battistero. Inoltre, quella porta è posta di fronte a via Calzaiuoli, in direzione di piazza della Signoria, per precisione che si tratta dell'ingresso principale.
17 -VILLANI 1823, vol. III, p. 10 .Villani indica il 1293 per la rimozione delle tombe, però c'è una testimonianza d'archivio che dimostra come essa avvenne nel 1246, quando venne iniziata la costruzione della nuova cattedrale. Cfr. W. PAATZ e E. PAATZ 1953, vol. II p. 265, n. 178.
18 -Cfr. ancora W. PAATZ e E. PAATZ 1953, vol. II, pp. 196-47, 206 e 207 con le relative e assai ricche note. E inoltre CHASTELL 1982, p. 33. Si sa che alla fine del Duecento fuori dal Battistero c'erano cinque sarcofagi, due di essi adesso sono all'interno, due altri, ora al Museo della Cattedrale, dove sono stati collocati dopo un ritorno agli inizi del XX secolo nel Battistero (lato meridionale) successivamente a un periodo in cui erano collocati in Palazzo Medici.
19 -ONDER 1970, p. 348 e la voce più ampia in GDLI, vol. 1, pp. 614-15. Per una definizione boccacciana cfr. BOCCACCIO 1965a, pp. 490-91 e 493.
20 -BOCCACCIO 1965a, pp. 490-91, 493, nel commento nell'Inferno, IX, 112-16.
21 -MCGREGOR 1984, pp. 1-42.
22 -Cfr. BOCCACCIO 1972, p. 504, e BOCCACCAO 1982, p. 401, Tutti i traduttori, peraltro, concordano nel dire che l'arca era assai alta; cfr. VI 9, 12: "arche, che grandi erano", Forse un esempio anteriore di erronea traduzione nella forma di una miniatura del xv secolo che accompagna una traduzione francese del Decameron (Parigi, Bibliothèque de l'Arsenal, ms 5070, f. 234v), illustrata in BOCCACCIO 1966, vol. II, P. 549. Qui l'artista mostra Guido seduto tra alcune lapidi non molto alte dal suolo. E questo perché egli unisce l'idea di tomba con l'usuale tumba a lastra in uso nell'Europa settentrionale: cfr. anche PANOFSKY 1964, p. 54 e tavv. 206, 208. Nel caso della miniatura le tumbae possono rendere più difficile una manovra di cavalleria, però non possono fornire alcun appoggio a Guido per volteggiarvi sopra.
23 -Cfr. nell'ill. 75 il disegno del ms It. 63 della Bibliothèque Nationale di Parigi (f. 203v), un testo scritto e illustrato a Firenze alla fine del 1427: Cfr. WATSON 1981, PP. 147-55, e qui, vol. II, pp. 104 sgg. L'artista descrive il Battistero con le colonne distaccate e mostra le arche quali erano effettivamente: grandi scatole di pietra, una delle quali ha tracce di un bassorilievo "all'antica":in altre parole un sarcofago classico.
24 -VASARI 1967, vol. II, p. 53 fa riferimento alla collocazione delle tombe all'epoca sua.
25 -Guido viene rappresentato proprio sul sarcofago illustrato nell'ill. 74 dal pittore fiorentino Tiro Lessi (1855-1917), in una illustrazione di un testo pubblicato da Alinari nel 1909, riprodotto poi nel volume popolare BOCCACCIO 1968a, p. 98. Il sarcofago, che Lessi ricollega con Guido e che pertanto ha anticipato quanto io sostengo, appartiene a una tipologia largamente diffusa nella tarda antichità, per la quale Cfr. RODENWALDT 1923-24, pp. 1-40, dove il sarcofago in questione è riprodotto come Abb. 8, pp. 17-18, una vecchia fotografia Alinari dalla quale si è ispirato pure Lessi; cfr. ancora KOCH e SICHTERMAN 1982, pp. 77-79. Cfr. anche la nota seguente.
26 -BOBER e RUBINSTEIN 1986, PP. 58-59. Bober e Rubinstein analizzano l'iconografia di questo sarcofago con cura e precisione. Esso presenta Mercurio nel modo classico, a differenza di come Mercurio veniva rappresentato ai tempi del Boccaccio - uno studioso in abito contemporaneo, come in un bassorilievo del 1340 circa, di Andrea Pisano - cfr. BECHERUCCI e BRUNETTI 1971, tav. 82. Questo venne scolpito per il campanile, dove il sarcofago era collocato ai tempi del Boccaccio. L'iconografia medievale di Mercurio solleva quindi il problema se la tipologia classica fosse stata riconoscibile nel Trecento.
27 -Ovidio, Metamorfosi, 1, 671 -72.
28 -Amorosa visione, XVII, 22-30; Teseida, VI, 38. Nel primo caso Mercurio figura in una pittura murale; nel secondo, è raffigurato nello scudo di Evandro. In entrambi i casi viene peraltro rappresentato come un pastore.
29 -BOCCACCIO 1951, vol. 1, PP. 77-79 (II, 7). Ci sono altri passi nel libro III, 20 e libro VII, 34 e 36.
30 -"Era opinione degli antichi che Mercurio avesse a trarre l'anime de' corpi e quelle portare dove gli piacesse", glossa a Teseida, X, 90, 2-5, in BOCCACCIO 1964b (cfr. la precedente nota 3), P. 595. Cfr. pure X, 94, 2-3 e XI, 3, 7-8.
31 -Cfr. altre osservazioni di Servio sull'ultima frase intesa come la morte dell'intelletto in SERVIUS 1961, pp. 508-9. Servio afferma inoltre che la virga di Mercurio si presenta avvinta da serpenti, tra l'altro, segnali di persuasività (SERVIUS 1961, p. 507). Nell'ill. 74, Mercurio reca proprio questo, il caduceo.
32 -Decameron, VI 9, 8 dice anche un'altra frase, piuttosto criptica; "a chiedere a lingua sapeva onorare cui nell'animo gli capeva che il valesse".
33 -BOCCACCIO 1951, vol. 1, p. 77 su Mercurio come "oracula vatum" e un'altra indicazione " acumen ingenii ". Tale parallelismo è stato proposto anche da DURLING 1983, p. 291, in cui si rileva che la sesta giornata del Decameron è un mercoledì, cioè il giorno di Mercurio; cfr. anche DURLING 1983, p. 304, nota 44.
34 -Eneide, IV, 276-78: "Tali Cyllenius ore locutus I mortalis visus medio sermone reliquit I et procul in tenuem exoculis evanuit auram".
35 -Cfr. ad esempio, gli affreschi del primo Trecento in Pisa, recentemente attribuiti a Buffalmacco, un altro eroe decameroniano, dove aristocratici viandanti, abbigliati col caratteristico copricapo fronteggiano i morti. Cfr. CALECA, NENCINI e PIANCASTELLI 1979, pp. 54-60.
36 -Cfr. KRAUTHEIMER 1969, pp. 131-41.
37 -Cfr. i casi citati da DU CANGE 1845, vol. V, p. 79. È incluso tra essi il resoconto di Leo d'Ostia sulla ricostruzione di Montecassino verso la fine dell'XI secolo in cui si fa riferimento all'atrio, "che noi, all'uso dei Romani, chiamiamo "Paradiso" ". L'usanza risale alla Basilica costantiniana di San Pietro in Vaticano. Cfr. inoltre DAVIS-WEYER 1971, pp. 137-81, e, per un riferimento vasariano del xvi secolo: GDLI, vol. XII, p. 536.
38 -Cfr, W. PAATZ e E. PAATZ 1953, VOI. II, p. 246, n. 129. Cfr. al tresì R.KRAUTHEIMER e T. KRAUTHEIMER-HESS 1956, vol. I, p. 18.
39 -BOCCACCIO 1980a, p. 756, n. 4.
40 -Concl. 6: " Egli [il pittore] faccia a San Michele ferire il serpente con la spada o con la lancia".
41 -Cfr. inoltre WITT 1946, vol. III, tav. I per il Giudizio universale in genere, tav. II per gli arcangeli e i demoni. Si consultino anche R0HLAND) 1977, pp. 34-74; ROSENBERG 1956, con molte illustrazioni; e ROJDESTVENSKY 1922. Nelle pp. 1-8 quest'ultimo autore tratteggia la primitiva assimilazione cristiana del culto pagano di Mercurio nella preesistente tarda venerazione ebraica e cristiana di Michele, un accostamento suggerito pure da Dante (Paradiso, IV, 47-63).
42 -DURLING 1983, pp. 282-83. Durling (e io stesso) potremmo essere stati anticipati dagli artisti del XV secolo citati nelle note 22 e 23, dove in entrambi i casi Guido sta seduto su una tomba rivolgendosi ai suoi ascoltatori. Entrambe le immagini evocano quella medievale della Resurrezione di Cristo. L'angelo seduto su un sepolcro vuoto, che si rivolge alle pie donne, all'alba della domenica di Pasqua. L'esempio più noto è quello di Giotto: Cfr. STUBBLEBINE 1969, tav. 52. tav. 52.